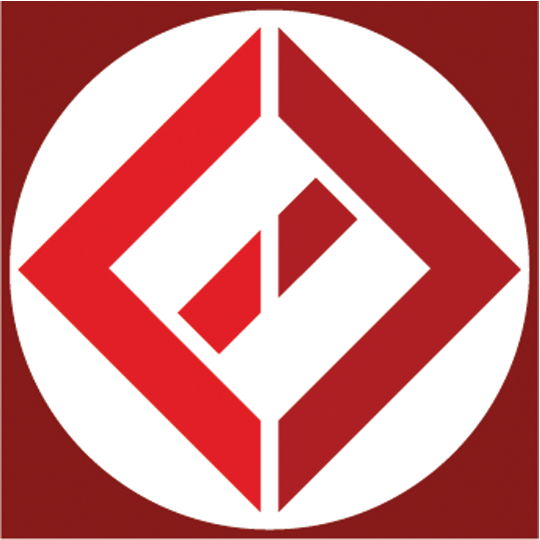Origini, classificazione e norme delle fibre tessili
Parlare di classificazione e norme delle fibre tessili significa tenere insieme origini, scienza dei materiali e regole del mercato: terminologia uniforme (ISO 2076), etichette corrette (Reg. UE 1007/2011) e prove analitiche affidabili (serie ISO 1833) sono l’ossatura di capitolati, conformità e difendibilità tecnica in caso di contenzioso.
Le prime fibre utilizzate nella storia del settore tessile furono quelle offerte dalla natura stessa. Tuttavia, pur esistendo più di 500 fibre naturali, in realtà sono molto poche quelle che possono essere utilizzate a livello industriale, poiché non tutte le materie possono essere filate e non tutti i filamenti e le fibre organiche si possono lavorare per la trasformazione in tessuti. La natura tessile di una materia deve comprendere le condizioni necessarie di resistenza, elasticità, lunghezza, aspetto, finezza, ecc. Nella loro forma naturale, e con l’unica eccezione della seta, le fibre hanno una lunghezza limitata, che può variare da 1 mm, nel caso dell’amianto, fino a 350 mm in alcune qualità di lane, che vengono denominate fibre discontinue. Chimicamente, si possono produrre fibre di lunghezza indefinita, simili al filo prodotto nel bozzolo del baco da seta e che vengono denominate filamenti: questi filamenti si possono tagliare per far sì che assomiglino alle fibre naturali (fibra tagliata).
Questa guida compatta aggiorna quadro e prassi operative per chi progetta prodotti, gestisce qualità o redige pareri e perizie.
Classificazione e norme delle fibre tessili: definizioni di base
Nel linguaggio tecnico, chiamiamo fibra un materiale flessibile e molto sottile, con alto rapporto lunghezza/diametro, idoneo a essere filato o impiegato in non tessuti. Le famiglie sono tre: naturali (vegetali e animali), artificiali (polimeri naturali rigenerati, es. viscosa, modal, lyocell) e sintetiche (polimeri sintetici, es. poliestere, poliammide, elastan). Questa tripartizione guida sia le scelte progettuali sia gli obblighi informativi. Le denominazioni dei materiali man-made sono normalizzate da ISO 2076.
Fibre naturali, artificiali, sintetiche
-
Naturali: cotone, lino, canapa, lana, seta.
-
Artificiali: cellulosiche rigenerate (viscosa, modal, lyocell).
-
Sintetiche: poliestere, poliammide/nylon, elastan… con nomi e criteri d’attribuzione definiti in ISO 2076.
| CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE TESSILI | |||
| FIBRE NATURALI | ANIMALI | da insetti seritteri | seta, seta selvatica |
| da bulbi piliferi | lana, alpaca, baby alpaca, lambswool, angora, bue, cavallo, coniglio castoro, cammello, cachemire, capra, guanaco, lama, lontra, mohair, kid mohair, vicuna, yack | ||
| FIBRE NATURALI | VEGETALI | dal seme | cotone |
| dalla corteccia | abaca, lino, canapa, juta, ramié | ||
| dalla foglia | alfa, alga, ginistra, kenaf, rafia, sisal | ||
| dal frutto | cocco, kapok | ||
| altre | sparto, banana, dunn, henequen, formio, agave, ananas | ||
| FIBRE NATURALI | MINERALI | amianto, fibre di vetro, fibre metalliche, fibre di carbonio | |
| FIBRE CHIMICHE | ARTIFICIALI
(se la materia prima esiste in natura) |
cellulosiche | viscosa, acetato, cupro, modal, carta tessile, lyocell, |
| proteiche | promix, lanital, ecc. | ||
| FIBRE CHIMICHE | SINTETICHE
(se la materia è un derivato del petrolio o del carbone) |
nylon, teflon, gore-tex, lycra, ecc. | |
Le fibre naturali da animale
Le fibre animali da insetti seritteri
La Seta è l’unica fibra animale prodotta da un baco serigeno che si nutre di foglie di gelso, il “bombix mori” o da altri bachi cresciuti sugli alberi (seta selvaggia “tussah”). La lavorazione della seta va dall’essiccazione alla trattura, cioè all’ammorbidimento in acqua calda e alla dipanatura. Da un bozzolo si ottengono da 800 a 1000 metri di filamento costituito da due bave a sezione triangolare combacianti. Essendo un filamento continuo molto sottile e lucente è leggera, termoisolante, elastica, flessibile ed è considerata la più fine e morbida tra le fibre naturali. Il filo può essere lungo e ritorto e quindi resistente, mentre la “bourette”, ottenuta dai cascami di seta della pettinatura, ha fibra corta ed è meno resistente. Tra i due filati c’è il tipo “shappe” discontinuo, che offre una buona resistenza.
Le fibre animali da bulbo pilifero
Alpaca: si ottiene dal pelo di un camelide che vive nelle Ande, molto simile al lama, ma più piccolo. La resa media è di 300 grammi di pelo per animale. Il vello all’esterno è grossolano e ruvido, mentre il sottopelo è morbido e lanoso con fibre di 24/25 micron di diametro.
Baby alpaca: è ottenuta dal pelo dei cuccioli di alpaca ed è particolarmente pregiata per finezza e setosità.
Angora: deriva dal pelo dei conigli d’Angora (allevati soprattuto in Cina) che sono tosati ogni tre mesi per ottenere circa 300 grammi di fibra. La fibra è lucente, calda e morbida e in genere mescolata alla lana perché delicatissima.
Cammello: si ricava dal pelo del camelide a due gobbe che vive nei deserti dell’Asia Centrale. Anche in questo caso non è il pelo superficiale a essere tosato, ma il morbidissimo duvet, che ha un diametro medio di 19/20 micron, in genere è rossastro e bruno chiaro e ha grandi proprietà termiche.
Cashmere: si ottiene per pettinatura del sottovello (o duvet) di capre allevate in Mongolia, Cina e Iran (meno pregiato). Il colore è generalmente bianco, ma vi sono tipi tendenti al bruno, rossiccio e al grigio. Il duvet cinese, forse il più fine, ha un diametro medio di 15 micron ( da 14,5 a 15,5) ed è morbidissimo, soffice e serico. Esiste inoltre il tipo “yangir” che ha il sottovello più fine in assoluto di circa 13/13,5 micron.
Castoro: da un roditore dei Castoridi dal corpo tozzo e robusto, si ottiene un pelo pregiato utilizzato anche per i feltri.
Crine: è il pelo della criniera e della coda di vari animali, specialmente del cavallo. E’ usato per imbottiture o in speciali tessiture.
Guanaco: è un camelide sudamericano che vive allo stato selvaggio. Anticamente era destinato a vestire gli imperatori e i sacerdoti andini. Il mantello è color frumento e, poiché è necessario uccidere l’animale per prelevarlo, già nell’antichitaà vi erano delle limitazioni nella caccia.
Lama: è un camelide sudamericano domestico dal mantello bianco, marrone bruciato, grigio e nero che all’esterno è folto e ordinario, mentre il sottopelo è lucido e caldo.
Lana: è la più diffusa fibra animale e si ricava dal vello di varie razze ovine (la più famosa è la pecora “merinos”), allevate in Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Sud Africa. Ne esistono molte varietà classificabili in base a finezza, lunghezza, colore, morbidezza e lucentezza. Ogni filo ha anche un titolo che è dato dal rapporto tra lunghezza e peso: più è alto il titolo, più fine è il filato. Grazie alla sua struttura e alla fitta crettatura delle fibre ha doti di igroscopicità (assorbe umidità in peso fino al 18/25%), coibenza (forte protezione termica), elasticità, resistenza all’usura e alla fiamma, ai piegamenti ed è in grado di perdere le antiestetiche pieghe. Dalle acque di lavaggio della lana si ricava la lanolina utilizzata per adesivi, lubrificanti e cosmetici. Marchi: il marchio “Pura Lana Vergine”gestito da Woolmark certifica che i capi sono in 100% lana di tosa e quindi non rigenerata.
Lambswool: contraddistingue la lana di agnello (tosato quindi intorno ai 4 mesi di vita) più apprezzata rispetto alla lana di pecora per alcune variazioni.
Lontra: da un mammifero dei Mustelidi si ottiene un pelo folto e morbido.
Mohair: è la capra d’angora (da Ankara) allevata nel centro dell’Anatolia, ma ora anche in Sud Africa e in Texas, a fornire questa fibra della finezza media di 25 micron. Il tipo più pregiato ha mantello color latte, ma esistono varietà nere, marroni e rosate. Il suo pelame è meno crettato di quello della lana da pecora e quindi è più lucido.
Kid mohair: si ottiene dai capretti d’angora. La sua fibra è più sottile del mohair, avendo una finezza media di circa 24 micron.
Vicuna: è un piccolo camelide sudamericano protetto dallo Stato peruviano. E’ grazioso, timido e velocissimo nel saltare. Il suo pelo molto fine (12/14 micron) e morbidissimo, soprattuto quello del collo. Il colore del mantello è quasi uguale in tutti i soggetti ed è color biondo/rossiccio. Si è temuto in passato per la sua estinzione, ora scongiurata da contromisure: viene allevato e pettinato per ottenere il prezioso duvet.
Yack: è un mammifero dei Bovidi che vive sugli altopiani tibetani ad altitudini tra i 4.000 e i 6.000 metri di altezza. Il pelo è grossolano ed è usato per stuoie e sacchi, mentre con il sotto pelo intorno ai 19 micron, si ottengono tessuti finissimi di colore scuro.
Le fibre naturali da vegetali
Le fibre vegetali da seme
Cotone: è la fibra vegetale più diffusa al mondo ed è tratta dalla capsula della pianta “Gossypium herbaceum” coltivata in Egitto, Sudan, Perù, in alcune isole tropicali, in California e in Cina. I cotoni si classificano a seconda del titolo, mentre la lunghezza delle fibre ne determina la qualità: più è lunga più il cotone è lucente, resistente e pregiato. Ha un’eccellente igroscopicità e quindi assorbe la traspirazione, buona tenacità, resistenza al calore, ottima adattabilità fisiologica e tingibilità. Poiché la sua resistenza aumenta quando è bagnata, è la più lavabile delle fibre anche ad alte temperature e con detersivi alcalini. Marchi: il marchio “Filoscozia” gestito dal Centro Promozione Filoscozia garantisce la qualità superiore dei cotoni pregiati a fibra lunga egiziani (Makò), pettinati, ritorti e mercerizzati in filo. Il filato ottenuto acquista una brillantezza serica.
Le fibre vegetali da corteccia (parte legnosa della pianta)
Abaca: detta anche “canapa di Manila” si ottiene da una pianta tropicale delle Musacee.
Canapa: è tratta dal fusto della pianta omonima delle Cannabacee. Caratteristica fibra rustica.
Juta: è ricavata dalle piante delle Tigliacee, utilizzata soprattutto per sacchi.
Lino: è la più antica e pregiata fibra naturale, tratta dal “libro”, lo strato corticale, del Linum usitatissimum. Proviene dall’unica pianta tessile coltivata anche il Europa e varia a seconda della sua provenienza (Belgio, Russia, Irlanda, Italia). Si ottiene da processi di macerazione della parte fibrosa: dal punto di vista chimico le cellule che compongono le fibre sono sia tenaci che elastiche. Per la sua particolare struttura molecolare ha doti di igroscopicità (assorbendo acqua fino al 12% del suo peso), resistenza all’usura, tenacia, durata, resistenza a lavaggi ad alta temperatura, comfort a contatto sulla pelle per la sua freschezza. Essendo più lucente del cotone, non deve essere mercerizzato. Marchi: il marchio “Master of Linen” del Centro Tutela Lino garantisce la qualità del lino prodotto, filato e tessuto in Europa Occidentale.
Ramiè: è tratta da una pianta erbacea perenne delle Urticacee.
Le fibre vegetali da foglia
Alfa: si estrae dalle lunghissime foglie di una pianta erbacea delle Graminacee delle regioni subdesertiche del Nord Africa.
Alga: si estrae dalle foglie delle alghe marine bianche e brune. Oltre all’utilizzo in farma – cosmetica, la pasta viene lavorata per ottenere una fibra dalle proprietà termoregolanti e con vantaggi per il benessere del corpo e della mente.
Ginestra: è estratta per macerazione dalla pianta omonima delle Leguminose.
Kenaf o ibisco: si estrae dall’Hibiscus, un genere di Malvacee tropicali.
Rafia: è fornita dalle foglie giovani di una palma dell’Africa Orientale, la “Raphia ruffa” e la “Raphia peduncolata”.
Sisal: è ricavata dalle foglie di una varietà di agave.
Le fibre vegetali da frutto
Cocco: si estrae dal mesocarpo del frutto della palma da cocco (noce di cocco) della famiglia delle Palme. Le fibre sono molto robuste.
Kapok: è la bambagia che riveste internamente la capsula del frutto di varie piante tropicali delle Bombacacee. E’ usato specialmente per imbottiture.
Le fibre chimiche sintetiche
Le fibre sintetiche organiche
Sono fibre derivate da sostanze organiche di sintesi che vengono polimerizzate ottenendo lunghe catene molecolari, le macromolecole, filabili sotto forma di filo continuo o di fiocco (fibra discontinua). La materia prima delle fibre sintetiche è fornita dalle industrie petrolchimiche. Filo e fiocco sono spesso disponibili già tinti (tinti in massa) dal produttore.
Acrilica: è una fibra costituita da macromolecole, prevalentemente di acrilonitrile,in genere usata sotto forma di fiocco, ed è disponibile anche in microfibra. E’ leggera, morbida, voluminosa, dalla mano lanosa e calda, irrestringibile, inattaccabile da muffe e microrganismi, con ottima tingibilità e resistenza alla luce solare. Marchi: “Courtelle” e “Amicor” by Acordis; “Drslon” by Bayer; “Leacril”, “Myloss” e “Ricem” by Montefibre.
Bullet Aramidica: è una fibra di poliammidi aromatiche, disponibile sotto forma di fiocco o di filo continuo. E’ resistente alla fiamma e nel caso del para-aramide (Kevlar) è anche resistente al taglio e all’abrasione. Marchi: “Kevlar” e “Nomex” by DuPont; “Twaron” by Acordis; “Tecnora e Conex” by Teijin.
Bullet Clorofibra: si ottiene dalla polimerizzazione del cloruro di vinile o del cloruro di vinilidene. Più che idrorepellente, la fibra è insensibile all’acqua mantenendotenacità, elasticità e allungamento sia a secco che a umido. E’ fr (flame retard). Marchi: “Rhovyl” by Rhovyl.
Bullet Elastan: è una fibra composta da una base di poliuretano segmentato a elevata elasticità mescolato con altre componenti. Non si deforma ed è resistente ai lavaggi. Ha elevata elasticità e allungamento fino 6 volte la lunghezza iniziale e mantiene inalterata nel tempo la sua forza di rientro. E’ resistente agli agenti ossidanti e all’acqua clorata. Può essere usata pura o, più spesso, in mischia con altre fibre conferendo loro elasticità. Marchi:”Lycra” by DuPont; “Dorlastan” by Bayer; “Linel” by Fillattice.
Bullet Flourofibra: è una fibra ottenuta da derivati flourati. Idrorepellente e termoresistente, è disponibile anche in forma di pellicola (membrana) microporosa per capi impermeabili. Marchi: “Teflon” by Du pont.
Bullet Gomma sintetica: ha proèrietà elastiche simili alla naturale ed è ottenuta con processi di polimerizzazione a caldo e a freddo in presenza di catalizzatori.
Bullet Modacrilica: è una fibra ottenuta da macromolecole costituite per almeno il 50% da acrilonitrile, disponibile generalmente in fiocco. Ha una mano morbida, ottima resistenza alla fiamma, tenacità, doti di coibenza termica, stabilità dimensionale, buona tingibilità. Marchi: “Lufnen” by Kanebo; “Kanekaron” by Kanegafuchi.
Bullet Poliammidica o nylon: è ottenuta da macromolecole contenenti il gruppo ammidico. E’ usata sia in filo continuo che in fiocco. Ha un’elevata resistenza alla rottura, alla deformazione e all’abrasione, è di facile manutenzione (lavaggio, asciugatura, no stiro), ottima tingibilità e ingualcibilità. E’ morbida e leggera. I fili sono prodotti in diverse sezioni per ottenere effetti estetici efunzionali ( ad es. il nylon trilobato è particolarmente brillante). Marchi: “Meryl” e “Meryl Nexten” by Nylstar; “Tactel” by DuPont Nylon; “Ortalion” by Bemberg; “perlon” by Bayer; “DoubleSix” e “Radilon” by Textile Produkte (Radici Group); “Noval” by Rhodia Performance Fibres; “Enka Nylon” by Acordis; “Aqualon” by Aquafil (Bonazzi Group).
Bullet Poliestere: si ottiene da macromolecole di polietilentereftalato (PET). Esiste anche in versione “flame retard” e come microfibra. Ha elevata resistenza alla rottura, elasticità e ripresa. E’ ingualcibile ed è una “lava indossa” (si lava falcimente, asciuga rapidamente, non occorre stiro). E’ disponibile anche nei tipi modificati a partire da macromolecole di polibutilentereftalato (PTT). I fili sono prodotti in diverse sezioni per ottenere effetti estetici e funzionali diversi. Marchi: “Terital” e “Fidion fr” by Montefibre; “Mirhon”, “Micrhon”, “Silkiss”, “Wolkiss” by Gruppo Miroglio; “Trevira” by Trevira; “Starlight” by Noyfil (Radici Group); “Pontella”, “Comforto”, “Corterra”, “Setila”; “Estrell” by Aquafil (Bonazzi Group); “Filanda”, “Airlain”, “TXT”, “Valtrompia” by Gruppo Sinterama; “Elitè” by Nylstar; “Diolen” by Acordis; “Dracon” by Du Pont; “Polifill”, “Terbond” e “Texbond” by Freudenberg Politex.
Bullet Polietilenica: a base di polietilene, è usata per l’estrema resistenza alla trazione. Marchi: “Spectra” by Allied; “Dyneema” by DSM.
Bullet Polipropilenica: è ottenuta da macromolecole di polipropilene isotattico, disponibile come fiocco o come filo continuo. Solida ai colori, leggerissima, ha elevata resistenza meccanica, buona resistenza all’abrasione, non assorbe i liquidi e quindi ha proprietà antimacchi, facilità di manutenzione ed è traspirante. Marchi: “Meraklon” by Meraklon; “Arlene” by Aquafil (Bonazzi Group).
Le fibre sintetiche inorganiche
Acciaio, rame, argento, zinco, titanio, oro: sono filati e usati in mischia con altre fibre per le loro doti di rigidità, preziosità (oro e argento), cromatiche e antistress (acciaio, rame e titanio).
Bullet Carbonio: le fibre sono ottenute per pirolisi o dell’acrilico pre-ossidato (PAN) oppure di un precursore a base di pece di petrolio. Hanno doti di altissima resistenza e di leggerezza. I fili sono spesso mescolati ad altri (ad es. a poliammide) nell’abbigliamento per ottenere performances “antistress” o effetti di mano. Marchi: “Panox” e “Silgrafilc” by SGLCarbon; “Fortafil” e “Tenax” by Acordis.
Bullet Ceramica: sono fibre a base di silicio, boro e alluminio modificati. Sono usate per la loro capacita di resistere ad altissime temperature e per la proprietà termoriflettente.
Bullet Vetro tessile: dalle fibre di vetro si ottengono veri e propri fili di vetro assai flessibili e sottili, continui o corti, di composizione variabile: sono usati in mischia per rinforzare altre fibre.
Altre fibre chimiche
Alcantara: è un marchio della Alcantara che identifica una serie di tessuti realizzati in mischie a base di ultra-microfibre di poliestere/poliuretano.
Bullet Lurex: è un marchio della “Sildorex”. Un film di poliestere o poliammide è metallizzato con vapori di alluminio o di argento e successivamente tinto per ottenere fili di aspetto metallico.
Classificazione e norme delle fibre tessili: nomi generici ISO 2076
La ISO 2076:2021 definisce i nomi generici per le fibre man-made in base al polimero principale e ai relativi attributi distintivi. L’uso coerente di questi nomi in capitolati, schede tecniche ed etichette riduce ambiguità e migliora la confrontabilità tra mercati. (Disponibile scheda ISO e anteprime/estratti ufficiali.)
Classificazione e norme delle fibre tessili: etichette secondo Reg. (UE) 1007/2011
Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 disciplina nomi delle fibre e indicazioni della composizione su prodotti tessili immessi sul mercato UE. In etichetta si usano solo le denominazioni ammesse (Allegato I) e si seguono regole specifiche per capi multicomponente, insiemi, accessori e casi particolari. Il testo consolidato su EUR-Lex riporta anche gli aggiornamenti agli allegati operati da atti successivi.
Composizione fibrosa e denominazioni ammesse
La descrizione della composizione deve riportare le fibre elencate in Allegato I con le relative percentuali. Le eccezioni e i casi particolari (componenti escludibili, elementi decorativi, insiemi) sono trattati dal Regolamento e nelle sintesi ufficiali. Un uso improprio di sinonimi commerciali o marchi al posto del nome generico non è conforme.
Parti non tessili di origine animale e tolleranze
Quando presenti parti non tessili di origine animale (pelle, pelliccia, piume), la menzione deve essere esplicita in etichetta. Il Regolamento stabilisce inoltre tolleranze e criteri di indicazione per miscele e componenti, utili nei controlli di mercato.
Nuove denominazioni: dossier tecnico (Allegato II)
Per introdurre una nuova denominazione di fibra, il produttore presenta alla Commissione un dossier tecnico con prove e caratteristiche, secondo Allegato II del Regolamento: la richiesta, se accolta, porta all’aggiornamento dell’Allegato I.
Classificazione e norme delle fibre tessili: analisi della composizione (ISO 1833)
La serie ISO 1833 descrive i metodi per l’analisi chimica quantitativa di miscele fibrose. La parte 1 (ISO 1833-1:2020) definisce l’impostazione generale e rimanda alle singole parti per coppie/triadi di fibre. La scelta del metodo (separazione manuale vs. chimica) dipende dal tipo di miscela e dall’intimità del blend. In ambito ispettivo/peritale, l’aderenza alla ISO 1833 rafforza tracciabilità, ripetibilità e difendibilità dei risultati.
Miscele binarie/ternarie e scelta dei metodi
Per miste binarie e ternarie la norma fornisce reagenti, condizioni e fattori di correzione; dove possibile, la separazione manuale garantisce maggiore accuratezza rispetto allo scioglimento selettivo, come indicato nelle note metodologiche. Documentare pre-trattamenti e incerature è decisivo per evitare scostamenti nelle percentuali finali.
Errori tipici e buone pratiche in etichetta
Errori ricorrenti: sostituire il nome generico con un marchio registrato; non indicare componenti con composizione diversa; omettere la menzione di parti non tessili di origine animale; non aggiornare i capitolati ai nomi ISO correnti. Buone pratiche: glossario interno con equivalenze ISO 2076 ↔ capitolati, schemi decisionali per i casi multi-componente, check di congruità analitica con metodi ISO 1833 prima del lancio.
Strumenti e link utili per PMI, uffici qualità e studi legali
-
EUR-Lex: testo consolidato del Reg. (UE) 1007/2011 e aggiornamenti.
-
Commissione europea: pagina di sintesi e aggiornamenti sull’etichettatura tessile.
-
ISO 2076: nomi generici delle fibre man-made (scheda ufficiale + anteprima).
-
ISO 1833: struttura della serie e parte 1 per analisi quantitative.
-
Dati settore (EURATEX): fotografie periodiche del comparto per contesto strategico.
Approfondimenti
Vuoi allineare capitolati, etichette e prove di composizione a ISO 2076/1833 e al Reg. (UE) 1007/2011? Supporto operativo, audit documentali e perizie tecniche per imprese e studi legali. Contattaci nell’AREA DI CONSULENZA